Punture di spillo. Parliamo di IA provando ad ascoltare gli altri
- a cura di Pietro Terna
- 27 feb
- Tempo di lettura: 4 min
a cura di Pietro Terna

Ho tenuto una conferenza – insieme a Franco Marra, ingegnere elettronico e portatore della cultura della vera Olivetti[1] – all’Associazione Culturale La Meridiana di Rivoli.[2] Il titolo assegnato era «Intelligenza Artificiale – Tra speranze e timori”. Per me, soprattutto gli aspetti economici. Un simpatico e attento pubblico; una bella occasione per discutere anche se io, stanchissimo, mi sono innervosito per una contestazione che ho valutato impropria, ma che avrei potuto far finta di non avere capito. Ai presenti ho consegnato un foglietto con la domanda: «Che cosa rappresenta per lei l’intelligenza artificiale? Rispondere in poche righe, anche una sola parola». Ho avvisato che ne avrei ricavato un breve articolo, eccolo.
Riferisco delle risposte raccolte[3] per trarne degli insegnamenti. La mia preferita afferma che è «L’inizio di Matrix»,[4] il film del 1999 (frame in basso) che racconta di un mondo fittizio in cui gli esseri umani credono di vivere liberi mentre sono vincolati a giacere in un liquido viscoso, collegati a cavi da cui ricevono illusori stimoli e false immagini da un mondo virtuale. Vegetano invece nello loro bare-culle e producono energia per le macchine padrone del mondo, dotate di intelligenza artificiale. Si capirà che il cielo è stato oscurato dagli umani per fermare le macchine che si erano ribellate. Trama e regia sono magistrali e si restava incollati alla poltrona nel cinematografo (niente home video, ai tempi) e anche si ritornava a vederlo. Se ne discuteva in modo serissimo, anche tra studiosi. Per un attimo, l’altra sera, ho rivisto le immagini gotiche della vicenda, ma non è così, sappiamo che non è così, sono più che sufficienti i drammi reali per rendere spaventoso il mondo.

Tornando alle risposte, molti dei presenti hanno espresso disagio, con frasi del tipo: «La grande paura per la perdita di forza lavoro e competenze professionali di tante categorie», «Paura. Le persone smetteranno di pensare? Ci sarà ancora pensiero personale e capacità critica? Quanto saranno protetti i grandi impianti necessari? Resisteranno alle infiltrazioni e alle guerre?», «A mio avviso AI dovrà essere normata con delle regole ferree, in quanto si presta ora e in futuro a situazioni non sempre legittime», «Un’opportunità straordinaria - Se utilizzata impropriamente può diventare un’arma pericolosa». Tutte frasi non prive di un contenuto di verità, ma che si fondano su una conoscenza non approfondita di quella cosa che ora chiamiamo intelligenza artificiale. Le novità poco comprese inducono a sopravvalutare i rischi.
All’opposto ci sono frasi positive come: «Una evoluzione accelerata dei processi informatici ai fini produttivi, gestionali, creativi etc.», « Una risorsa per il futuro dell’umanità, naturalmente con principi di etica di etica, morale al servizio della persona e del bene comune e della dimenticata fraternità planetaria (liberté égalité fraternité)», « Il futuro della specie umana dipende dalla sua capacità di adattarsi all’uso di nuove “protesi”. L’IA è l’esoscheletro dell’intelligenza naturale », « Per me rappresenta la capacità di risolvere i problemi, uno strumento al servizio dell’umanità - Ma ci possiamo fidare delle risposte?». Ora siamo dalla parte opposta, quasi con una sopravalutazione degli aspetti positivi, certo con qualche opportuno dubbio come nell’ultima risposta.
Ne traggo la conferma che è necessario spiegare molto bene quali sono i limiti e le potenzialità di questo aggeggio che chiamiamo IA, indipendente dal clamore provocato dai miliardi e dai miliardari, a partire da Musk, con Trump che li osserva benignamente. L’altra sera il mio compito era parlare degli eccessi di borsa intorno alle aspettative destate dall’IA, altrimenti avrei provato a mostrare un piccolo film preparato per ragazzi e ragazze di seconda media. Lo propongo qui, sperando di non offendere nessuno: è molto semplice, ma è tutto giusto.[5]

Ops, e se invece fossimo immersi in una realtà virtuale come in Matrix, con altri che ci guardano come se fossimo protagonisti ignari di uno spettacolo alla Truman show,[6] film dello stesso periodo – 1998 – che racconta di un piccolo mondo costruito per racchiudere la vita di una persona e permettere a una stazione televisiva di mostrarla a tutti come se fosse uno spettacolo. Siamo confinati in una specie di Matrix o Truman show? Certamente non è così è la controprova e che se fosse tutto virtuale il regista oscurerebbe almeno in parte gli orrori del mondo. Controcanto: e se piacessero agli spettatori che ci guardano? Che groviglio.
Per fortuna il nostro piccolo baccelliere di musica,[7] per me sempre grande o grandissimo, arriva al momento giusto per concludere lo spillo, come da tradizione. Ci ricorda che evolversi è uscire dagli schemi. Si procedeva a quattro zampe. Poi qualcuno assunse la posizione eretta e ne venne fuori l’uomo con tutte le sue contraddizioni. Questa capacità evolutiva, che è essenziale alla creatività, sembrava preclusa alle macchine. La nuova intelligenza artificiale sembra però aver fatto un ulteriore (grande?) balzo in avanti. Ci spingiamo ad ipotizzare che questi strumenti possano acquisire, come dice Giuseppe Trautteur (foto in alto) in una recente intervista, «coscienze che sanno ciò che stanno facendo».[8] Normale che questi aspetti spaventino ed entusiasmino nel medesimo tempo. Più facile è trovare un aggancio a temi musicali.

Se guardiamo la storia della musica può apparire come un percorso lineare che ha visto l’umanità partire da istanze piuttosto semplici e via via dedicarsi a forme sempre più complesse, ampie negli organici e sofisticate, sino ad arrivare alla loro forzatura e di fatto alla stessa negazione dei cardini sui quali poggiavano. È piuttosto curioso constatare come questo processo sia stato conosciuto dalla musica colta, passata in otto secoli dal canto Gregoriano a Stockhausen, ma anche dal jazz stesso, in un periodo molto più breve che va da New Orleans al Free Jazz di Ornette Coleman. Il risultato è che, come Alessandro Magno di fronte al mare, i musicisti moderni si ritrovano senza più terra da conquistare.[9] Per noi, orfani, non rimane che tornare indietro e dedicarci all’ascolto dell’apertura del Second Sacred Concert di Duke Ellington,[10] una delle sue ultime opere, nella quale seppe condensare i frutti della propria personale evoluzione.
Note
[5] Un riferimento scherzoso: spiegare le LLM a ragazze e ragazzi di seconda media: https://terna.to.it/provaBEM/provaBella.mp4
[7] L’anonimo coautore che cita nel suo pseudonimo di piccolo baccelliere un verso di Guccini (in Addio) esiste, esiste veramente.
[8] Intervista pubblicata sul numero del 25 settembre de La Repubblica, https://www.repubblica.it/cultura/2025/02/24/news/il_fisico_giuseppe_trautteur_l_ia_e_gia_pronta_a_sviluppare_una_coscienza-424025469/
[9] Chissà se potrà aiutarli l’intelligenza artificiale.


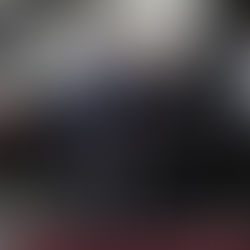



































Comments