ORIZZONTI D'EUROPA
- Mercedes Bresso
- 1 mag 2024
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 4 mag 2024
La nona legislatura europea si è chiusa
di Mercedes Bresso
E così è finita. Con la plenaria della settimana scorsa, anche questa legislatura si è chiusa e sono tempi di bilanci. È stata insieme straordinaria e complicata: proverò a raccontare perché. Anzitutto è iniziata con l’elezione di una donna a Presidente della Commissione: era la prima volta e Ursula Von der Layen è stata in questi anni la donna a capo di un esecutivo tra i più grandi del mondo, quasi mezzo miliardo di persone. Non proprio un primo ministro, ma un ruolo chiave sullo scacchiere mondiale. Prima di lei solo Indira Gandhi aveva governato un paese più grande e con il doppio di abitanti, l’India. Una svolta epocale anche per l’Europa che, dopo la morte del bravissimo e rimpianto Davide Sassoli, ha eletto un’altra donna, Roberta Metsola, a Presidente del Parlamento Europeo.
Così la legislatura si chiude con due donne nei posti più importanti e entrambe hanno dimostrato capacità, fermezza, visione. Ursula sarà la candidata del PPE anche per la prossima tornata, mentre noi socialisti e democratici avremo Nicolas Schmidt, il bravissimo commissario alle politiche sociali, che purtroppo potrà ricoprire la carica solo se noi fossimo il primo gruppo del nuovo Parlamento, cosa assai difficile anche se non impossibile.
Gli effetti della pandemia
Avere avuto una donna a capo della Commissione è stato probabilmente un atout per l’evento che ha caratterizzato la prima parte della legislatura: il Covid 19. La pandemia è stata una prova molto dura per l’Unione che, secondo i trattati, non aveva competenza in questa materia. Eppure una volta di più abbiamo dimostrato di saper affrontare le crisi: la Commissione ha negoziato prezzi e quantità dei vaccini per tutti i paesi evitando la competizione fra noi che avrebbe gonfiato i prezzi e ritardato gli arrivi. L’Unione ha anche rapidamente approvato SURE lo strumento finanziario che ha garantito la cassa integrazione a milioni di lavoratori europei durante la pandemia. E, da ultimo, si è per la prima volta indebitata, altra cosa non concessa dai trattati, per mettere a disposizione dei paesi più colpiti, con il Next Generation UE , più di 700 miliardi di euro finalizzati allo sviluppo delle economie indebolite dalla crisi. Quello che in Italia, il paese che ha avuto di più, si chiama PNRR. Ora dobbiamo sperare che nella prossima legislatura si possa definire uno strumento permanente per il finanziamento delle transizione climatica e digitale e per la politica di difesa comune che metta l’Europa in grado di affrontare le nuove sfide non solo nell’emergenza.
La guerra in Ucraina
Ma non era finita: per la seconda volta dalla fine del secondo conflitto mondiale (la prima era stato
la ex Jugoslavia) ci siamo trovati con la guerra sul territorio europeo. E senza una politica estera e di difesa comune, anche se nella precedente legislatura era stata istituita una cooperazione strutturata sulla difesa, che sta lavorando a omogeneizzare i sistemi di difesa finanziando progetti industriali comuni, a garantire che ovunque sul territorio possano transitare i mezzi pesanti, insomma a costruire ciò che è permesso dai trattati che, ad oggi, prevedono se non il coordinamento costituito dall’alto rappresentante (attualmente Josep Borrell) senza nessuna competenza specifica. Eppure l’Europa è riuscita a essere il secondo partner dell’Ucraina sul piano dell’aiuto militare e ha accolto sei milioni di rifugiati sul proprio territorio, in barba alle politiche migratorie restrittive. Molto per le competenze attuali, poco se vogliamo tornare ad essere una potenza mondiale.
Questa è stata anche la legislatura del Green deal, la grande scommessa europea su come riuscire a raggiungere la neutralità climatica (cioè non emettere più CO2 di quanta ne riusciamo a fissare). La Commissione ha lanciato il patto con la prima presentazione del programma e in cinque anni sono stati approvati circa 170 provvedimenti che hanno modificato quasi tutte le normative ambientali pregresse. Malgrado le polemiche inevitabili con chi pensa che si possano raggiungere obiettivi difficili solo parlandone, il quadro generale del progetto è grandioso e rappresenta la più importante realizzazione concreta da parte di un intero continente per rispettare gli accordi internazionali sul clima: se qualcuno ce la farà sarà l’Europa. Certo nella prossima legislatura ci sarà da affinare e magari rivedere alcune norme varate un po’ in fretta ma non c’è dubbio che questi provvedimenti portano l’Europa a essere leader nella grande sfida climatica mondiale.
La riforma dei trattati
Il mio ultimo intervento in Parlamento è stato proprio su un provvedimento del Green deal, di cui ero relatore ombra, quello sulla riparabilità dei beni: il 77% dei consumatori europei desidererebbe poter riparare i beni durevoli che si guastano, invece di essere spinto a sostituirli: la norma detta tutta una serie di regole per garantire che questo possa avvenire, assicurando la disponibilità dei pezzi di ricambio, anche per gli indipendenti, prolungando le garanzie, definendo misure per facilitare e incentivare le riparazioni. Una norma interessante per i consumatori europei e per l’ambiente, che sono stata lieta di contribuire a mettere a punto e ad approvare.
Proprio dai problemi che ho esposto è nato l’ultimo atto chiave di questa legislatura, quello a cui anch’io ho avuto il privilegio di partecipare, prima lavorando sui testi e poi come parlamentare della commissione Affari Costituzionali. È la formale richiesta, ai sensi dell’articolo 48 del trattato, da parte del Parlamento, di avviare una Convenzione per riformare i trattati stessi. Per chiederla il Parlamento deve elaborare una proposta indicando tutte le modifiche che intende proporre. L’atto viene in seguito verificato dal Consiglio e trasmesso al Consiglio Europeo che deve decidere se darvi seguito.
Il Parlamento ha lavorato sulle proposte fatte dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, anch’essa tenutasi in questa legislatura, con la partecipazione oltre che delle istituzioni europee e nazionali, anche dei rappresentanti dei portatori di interessi e di cittadini e movimenti. E ha prodotto un testo di grande qualità, approvato il 23 novembre, che disegna un’Europa con poteri concorrenti in politica estera, difesa e sicurezza, che ha un’autonomia fiscale e nel quale le due Camere, Consiglio e Parlamento votano a maggioranza ( nel primo caso degli Stati e dei cittadini) e sono ci-legislatori alla pari. Viene inoltre introdotta una competenza esclusiva sugli accordi internazionali sul clima e delle competenze concorrenti in materia di industria, salute, diritti sociali dei cittadini. Una Istituzione, insomma, che comincia ad assomigliare a quegli Stati Uniti d’Europa che sono il sogno e l’obiettivo di noi federalisti.
È stato per me un grande onore potere partecipare al voto di questa proposta che, anche se approvata con una maggioranza risicata, è la prima adottata dal Parlamento dopo quella del 1984 promossa da Altiero Spinelli, il nostro grande federalista che continua a guardare tutti quelli che entrano al Parlamento nell’edificio intitolato al suo nome, da una gigantografia, con le braccia incrociate e lo sguardo severo, quasi a ricordarci il nostro dovere di completare quel percorso arduo di una futura federazione europea che lui ha iniziato da Ventotene, prima ancora che la guerra finisse e che ha animato l’azione di tanti di noi.
Un futuro "sempre più unitario"
È stata in sostanza una legislatura all’insegna del sogno di un futuro “sempre più unitario” e della concreta realtà di tante realizzazioni positive per i cittadini del nostro continente e che ha anche avviato un ulteriore allargamento dei confini della nostra Unione, aprendo alla candidatura dell’Ucraina e della Bosnia Erzegovina, oltre che, sia pure in tempi più lunghi alla Moldavia, alla Georgia e ai Balcani Occidentali. Una Unione che potrebbe arrivare verso la metà del secolo, quando starà per compiere i suoi 100anni, a 35-36 Stati Membri, raggruppando davvero quasi tutto il vecchio Continente.
Tuttavia gli ultimi atti approvati non sono entusiasmanti:
- il nuovo patto di stabilità con luci (una cauta introduzione della golden rule, che esclude dal debito gli investimenti di cofinanziamento di fondi europei e che per la prima volta introduce nei rapporti sull’economia dei Paesi anche gli elementi sociali) e molte ombre, come quella di non prevedere nuovi finanziamenti comuni per le materie strategiche come clima, digitale e difesa.
- Il provvedimento sulla gestione del fenomeno migratorio, che ha partorito un provvedimento di poco migliore del famigerato accordo di Dublino.
Che cosa succederà nella prossima legislatura? Molto, tutto forse, dipende dai risultati elettorali. Per la prima volta infatti si confrontano due diverse idee di Europa.
La prima, quella dei partiti tradizionalmente pro europei che con diversi distinguo vogliono però andare verso una sempre maggiore integrazione, che ormai non può che sfociare in un sistema di tipo federale perché senza una politica estera e di difesa comune rischiamo di trovarci soli e deboli di fronte all’aggressività dei nuovi Stati Continente, la Russia, la Cina, l’India e altri.
La seconda, quella delle destre illiberali e dei loro governi, che non hanno più il coraggio di rifiutare l’UE ma che la concepiscono come una debole unione di Stati che si riprendono quasi tutti i loro poteri, compreso il mercato unico, che ha fatto la prosperità del Continente dal dopoguerra ad oggi, mentre le attribuirebbero una parvenza di competenza in materia di difesa, senza però ammettere che questa non avrebbe senso senza una politica estera comune e un impianto istituzionale federale. Costoro, compresa Meloni, parlano di una Confederazione di Stati, ma non dicono che cosa intendono con questo nome. Soprattutto, per quanto è dato sapere, vorrebbero mantenere l’unanimità nelle decisioni e quindi continuare con la debolezza imbelle e le indecisioni di oggi.
Come diceva Pierre-Michel Foucault (1926-1984), il potere viene dal basso, cioè dai cittadini europei che, con il loro voto, ci diranno se vogliono uscire dalla storia futura del mondo o scrivervi una nuova pagina, con il coraggio e il senso del nostro ruolo che vorremmo giocarvi.































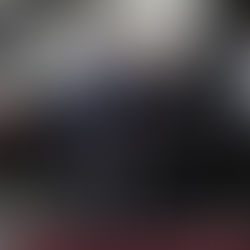








Commentaires