La serata del Sinodo a Torre Pellice: quando il “filo rosa” si tinge di rosso
- STEEME COMUNICATION snc
- 22 ago 2023
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 22 ago 2023
di Piera Egidi Bouchard

Il “filo rosa” del tema del “genere” si tinge di rosso – il sangue di tante vittime – nella “Serata pubblica del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste” che avviene, come di consueto, il lunedì sera al Tempio di Torre Pellice. “Oppressione, resilienza, trasformazione: donne nello spazio pubblico”: questo il tema complesso di un confronto a più voci, coordinato dalla giornalista Susanna Ricci e intervallato da bellissime musiche di compositrici dalla pianista Magali Gonnet.
“Esiste un tempo in cui le donne contribuiscono alla trasformazione del mondo e dell’uomo? – si è chiesta Ricci introducendo il dibattito – Come viene trasformato ora lo spazio pubblico dalla presenza delle donne – in un tempo di cambiamenti che spinge all’individualismo, nello spazio virtuale dei media -? “Questo tempo è adesso- ha risposto la teologa Daniela Di Carlo- è ora di riconoscere il ‘peccato di genere’ determinato dal fatto millenario che gli uomini si sono appropriati della somiglianza con Dio ”.
2015: nasce “Non una di meno”
“ E ha ricordato una data significativa, il 2015, quando è nato in Argentina, sviluppandosi poi in tutto il mondo, il movimento “Non una di meno”, che si propone di praticare un “femminismo intersezionale”, cioè di mettere insieme tutti i soggetti oppressi, e insieme trasformare il mondo.

Purtroppo la pandemia del Covid dal marzo 2020 ha ricacciato le donne in casa, rinchiudendole; però esse hanno reagito creando una rete virtuale. E dal 2015” c’è stata una grande trasformazione: la consapevolezza e l’esigenza che il linguaggio non può più essere il linguaggio maschile, ma deve diventare plurale, dare voce- anche nelle liturgie delle chiese -alla diversità. E’ questo un discorso enorme, ma che c’è già: le donne già occupano lo spazio pubblico, si tratta di “far rete”, di mettere in atto legami, se no nessuno si salva. Oggi, adesso- ha concluso - è il momento di vedere quello che le donne hanno detto e continuano a dire”.
Asmae Dachan, scrittrice siriana, attivista per la pace e la nonviolenza, ha voluto parlare qui in quanto giornalista, cioè di situazioni che ha visto in prima persona nel mondo. E ci ha parlato della Siria, da 13 anni dilaniata da una guerra che ha causato milioni di profughi, così come l’Etiopia, anch’essa travolta da più guerre, dove le donne non riescono a denunciare le violenze e gli stupri, per un malinteso senso di vergogna, e subiscono un isolamento che spesso le porta al suicidio. E nella Tanzania sussiste il fenomeno di donne e bambine usate come schiave domestiche nelle famiglie più abbienti.

Nelle tante situazioni di guerra e di fame, se riescono a fuggire, le donne si ritrovano senza documenti, senza cellulare, e se approdano con infinite difficoltà e chilometri a piedi e attraverso il mare sulle coste europee della Grecia, dell’Italia e anche della Spagna, finiscono in un campo profughi, o anche “spariscono”, e le ritroviamo sulle strade, come anche i minori, oggetti di sfruttamento sessuale. “La resilienza significa prendere il dolore e trasformarlo in forza” – ha detto. E ha concluso citando Virginia Woolf, con l’auspicio che “una stanza tutta per sé, un privilegio per molte di noi, possa diventare un luogo protetto e creativo per ogni donna.
In Italia, 75 donne uccise dall’inizio del 2023
Annalisa Camilli, giornalista, ha esortato a ricordare i nomi di tutte le 75 donne uccise in Italia[1], e si è soffermata sulle ultime tre, recentissime, accomunate dal fatto che queste vittime avevano denunciato la violenza del partner, ma non sono state credute, e che - pur in storie diverse, in classi sociali diverse - sono state uccise da un uomo che avevano chiamato “amore”. E ha citato il saggio di Lea Melandri “Amore e violenza”, così come “Il disagio della civiltà” di Freud.

“In realtà la violenza - precisa - non avviene su un soggetto debole, ma su un soggetto forte, su persone che avevano reclamato per sé un percorso di libertà: è il balzo in avanti delle donne nella società ad aver alimentato la violenza su di loro: essere ‘visti’ significa essere preda.” Questa situazione ha fatto emergere anche la vulnerabilità e la fragilità degli uomini, che si confrontano con la fine della ‘legge del padre’, e quindi ripristinano modelli arcaici del patriarcato.
Alcuni giovani, però, sono in ricerca: “Ho saputo ad esempio che dei ragazzi si sono rivolti a Ravenna alla Casa delle donne, perché vorrebbero imparare come fare un percorso di autocoscienza, capire come conoscere in sé le radici della violenza. Gli uomini dovrebbero prendere la parola – ha concluso – e le donne non dovrebbero mai essere lasciate sole, bisogna imparare a reagire ai soprusi, a parlare. Perché il coraggio è contagioso. E’ un esercizio collettivo”. E ha citato il ricordo di una donna coraggiosa, Michela Murgia. Ricci ha poi ricordato il libro di Cecilia Strada - che non ha potuto essere presente - “La guerra tra di noi”, che indica il percorso di poter anche in tempi di guerra costruire pezzi di pace.

Sconfiggere il divide et impera
La moderatora Alessandra Trotta, avvocata, diacona metodista, ha tratto le conclusioni, spiegando l’origine delle tematiche proposte nella serata: “Cercavamo un modo di evidenziare il divide et impera attuato da sempre per indebolire le persone, imprigionandole in un isolamento individuale, egoistico, che è in tutti gli ambienti e occupazioni del nostro mondo attuale. Oggi è un’epoca del più basso impegno ‘politico’, ma assistiamo al fatto che sono le donne ad essere soggetti politici, e non solo in Occidente. E’ quindi adesso il momento propizio per operare un cambiamento complessivo, perché le donne nei loro discorsi pubblici ci hanno raccontato di un quadro intersezionale, ponendo anche i temi della pace, della libertà, della cura dell’ambiente, della protezione delle nuove generazioni. Nello spazio pubblico porto quindi la battaglia non solo per me, ma per tanti altri soggetti oppressi.”
“Quali possono essere dunque gli strumenti per una trasformazione? - si è chiesta. Innanzitutto la solidarietà, il mettersi in squadra per resistere. Poi bisogna operare affinché il linguaggio diventi inclusivo, rappresenti il mondo nella sua pluralità, nelle diversità esistenti. In terzo luogo, è necessario ricordare i nomi per dare voce a chi non c’è più per sottrarle all’invisibilità: (nelle nostre chiese ci sono le scarpe rosse che indicano le vittime di violenza). Bisogna evitare la reazione difensiva di ‘non essere visti per non essere prede’. Ma dobbiamo essere visti e non essere prede. Per tutto ciò dobbiamo attuare un esercizio collettivo di coraggio.”
E ha indicato infine l’albero-bacheca in fondo al tempio, che sarà portato nella Casa sinodale, in cui ciascuno/a può appendere un foglietto con una parola, una frase, una riflessione su questi temi, che costituirà un filo rosa presente nelle parole e negli interventi del Sinodo.
Note
Si ringrazia per le foto Pietro Romeo (Riforma)









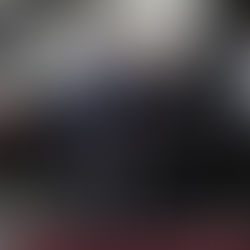




























Comments