Dazi, primo test dell’incapacità di scegliere la convivenza civile
- Emanuele Davide Ruffino e Germana Zollesi
- 16 ore fa
- Tempo di lettura: 5 min
di Emanuele Davide Ruffino e Germana Zollesi

A tutti i livelli, dai rapporti internazionali alle relazioni personali, il Millenium si sta caratterizzando per una sempre maggiore incapacità di regolare le relazioni sia a livello individuale che collettivo. Dissimili, ma in forte crescita, sono le cause che portano a rendere ostiche le diverse forme di convivenza: c’è una convergenza nel dire che la nostra società - sempre più complessa - si stia velocemente complicando, ma più articolata è l’analisi sulle ragioni che hanno portato ad un livello vicino al caos, non solo sui mercati finanziari.
Non si ha più fiducia degli alleati storici (non sempre a torto), nelle istituzioni pubbliche (sovente impegnate in lotte fratricide), ma anche nel nostro vivere quotidiano, dai rapporti con il vicinato alle relazioni affettive. I mass media riportano moti di una violenza inaudita e inspiegabile, a cominciare dai femminicidi per i quali gli autori, oltre alle scuse di circostanza, non sono in grado di articolare una spiegazione dei loro agiti. Una giustificazione per questa acredine è difficile da individuare senza cadere in spiegazioni manichee o semplicistiche, anzi l’intellettualismo che si sforza di offrire chiarimenti rischia di diventare un esercizio astratto ed un po’ inconcludente.
Caos internazionale
Il terremoto provocato dai dazi e dai contro-dazi potrebbe segnare la fine della globalizzazione, così come era stata concepita, facendo naufragare la possibilità di un governo sovranazionale, rendendo di nuovo necessaria la presenza di uno "sceriffo", cioè il soggetto in grado di far rispettare gli accordi: ruolo che non potrà più essere riconosciuto agli Usa, anche perché gli americani sono riluttanti a interpretarlo sine die. Il problema è che la mancanza di uno sceriffo, anche se fallibile, ha portato ad un incremento dei conflitti: più di 50 attualmente in corso, ma solo alcuni richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica. S’invoca la pace come un totem taumaturgico, cui però non si riesce a dar corso, ed insufficienti sono pure gli interventi dell’ONU, che hanno rischiato di avvantaggiare una delle parti in competizione (comprese quelle meno rispettose degli accordi). Ora che lo sceriffo si dice stanco di continuare ad avere la stella sul petto, l’unica discussione sembra incentrarsi su quanto impegnarsi finanziariamente e militarmente, ben sapendo che chi alza la bandiera del non spendere in armamenti o nel non impegnarsi in conflitti, come nel 1939, acquisisce maggiori consensi (anche se ciò comporta rinnegare la loro storia recente), ma poi le alleanze dovranno tornare a riformarsi sulla condivisine dei valori fondanti la visione della società. Nessuno, sano di mente, vuole le guerre, ma una volta che queste sono scatenate (in Ucraina, nei kibbutz presi d’assalto in Israele o sul terreno dei dazi commerciali), poi le devono combattere, con determinazione, anche chi non le ha volute.
Caos economico
Dopo più di un decennio che dagli USA arrivano segnali d’insoddisfazione per le mancate reciprocità delle condizioni di scambio con gli altri Paesi (di cui i dazi sono solo una componente, ma altrettanto incisivo sarebbe stato il programma di investimenti avviato da Biden di 1.000 miliardi di dollari per attrarre investimenti negli Usa) è arrivato un pokerista che si avvale del maggior livello di autosufficienza rispetto agli altri giocatori, per ridiscutere tutte le regole del gioco, iniziando a togliere i finanziamenti agli organismi internazionali, come il WTO e l’OMS, deputati a dirimere le dispute: organismi che vedevano gli Usa nell'incomoda situazione di finanziare ed essere poi maltrattati e criticati.
Forti del fatto che, se si mette a rapporto l’import-export di un Paese con il suo PIL, cioè la dipendenza dal resto del mondo, gli Usa sono sicuramente i più autonomi e quindi i “meno svantaggiati” in un eventuale esasperazione dello scontro, si è iniziato un conflitto dagli esiti imprevedibili. Dunque, sarà necessario agire con molta oculatezza nello svalutare le monete e nel rivedere i tassi di interesse per reggere le conseguenze della guerra dei dazi, ma questi ormai sono parametri non più sotto il controllo della politica, come dimostra lo scontro Trump-Powell del post liberation day: saranno poi le pagine di storia economico-finanziaria a rilevare se alcune informazioni allarmistiche sono state diramate ad arte per trarne profitto. Oggi, 7 aprile, le borse asiatiche sono tutte in discesa libera, da Tokio (il Nikkei ha perduto quasi l'8 per cento in chiusura) a Hong Kong, a Shanghai, a Seul.
In questo scenario, poco libero e liberale (i dazi, come le tasse, la burocrazia e i deficit eccessivi sfasano le regole del mercato), le forze politiche occidentali sembrano più impegnate ad accusare gli avversari politici locali o rimarcare che anche chi impone dazi potrà avere ripercussioni negative, che non a ragionare su come si stabilisce regole di un commercio equo e solidale, condizione affinché tutti possano progredire (ma per realizzare queste condizioni devono contribuire tutti, e non rinviare ad altri le responsabilità).
Caos istituzionale
Se la separazione dei poteri ha rappresentato una fondamentale evoluzione del mondo civile, oggi tale equilibrio sembra essersi logorato (in Francia, negli Usa ed ovviamente anche in Italia che, forse ne è stata l’antesignana): in diversi Paesi lo scontro tra la volontà popolare, sempre meno spontanea causa le fake news e i detentori dell’interpretazione delle norme, sempre più casta sacerdotale, si fa sempre meno sostenibile.
Ad essere messa in discussione è la stessa formalizzazione del potere non più costruito intorno ad una visione sul futuro delle società, ma su parametri identitari e fugaci che non permettono d’identificare criteri duraturi di aggregazione su programmi di lungo periodo. Il potere non risiede più nella politica, ma in altri contesti: quello economico delle banche centrali (o forse già nelle criptovalute), quello mediatico dei social, dove diventa sempre più difficile distinguere il vero dal falso, nella regolazione della vita sociale dove le organizzazioni di volontariato ricoprono un ruolo tanto importante quanto incontrollabile e nella magistratura che, più che applicare le norme, le interpreta e le riscrive.
Ormai le componenti sociali si stanno radicalizzando ognuna nelle sue posizioni e sono portare a credere che solo in queste esasperazioni è possibile conservare il loro potere, incuranti degli effetti deleteri che questi atteggiamenti inducono nella società. Il benessere collettivo perde importanza rispetto al mantenere o conquistare una posizione di maggiore potere o semplicemente una posizione identitaria.
Il caos interpersonale
Tutti pronti a lamentarsi del caos creato a livello internazionale, economico e istituzionale, ma poi le notizie di cronaca riferiscono di episodi cruenti perpetrati con una superficialità imbarazzante che testimoniano come la convivenza è stata minata nelle relazioni sociali già a livello famigliare o nelle interrelazioni personali. Gli episodi di violenza per questioni futili o la pretesa di avere dagli altri comportamenti impossibili (in ultimo quello di un medico del Pronto soccorso che si è visto puntare una pistola alla tempia e minacciato di morte se non salvava la mamma) avvengono con frequenza sempre maggiore, al punto da far chiedere se siamo ancora capaci di convivere con i nostri simili.
Già Aristotele, pur considerando l’uomo un animale sociale, non riteneva la convivenza un fatto naturale, ma una costruzione complessa, quasi un artificio. Per convivere occorre istituire delle condizioni, basate sul bene comune, che rendono possibile e conveniente la convivenza stessa, che si raggiunge solo quando la maggioranza dei cittadini agisce correttamente e c'è fiducia tra loro e le istituzioni. Per Aristotele, gli esseri umani, se lasciati a sé stessi, più che convivere, confliggono, e la realtà odierna ne è una drammatica conferma: il problema è che oggi non vi è più un’autorità riconosciuta per svolgere il ruolo di regolatore, né noi nel nostro microcosmo siamo più in grado di gestire rapporti normali e, di conseguenza, il caos rischia di prevalere se non si riesce a stabilire un nuovo ordine condiviso e rispettato. Sia pur con tutti i difetti, solo le democrazie, per la loro insita resilienza e la loro capacità di coinvolgimento, possono rispondere a queste esigenze.

















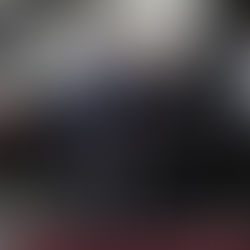






















Comentários